![]() Francesco Russo - Direttore Spiralis Mirabilis, studioso, praticante e insegnante di arti marziali tradizionali cinesi
Francesco Russo - Direttore Spiralis Mirabilis, studioso, praticante e insegnante di arti marziali tradizionali cinesi
Pagina pubblicata in data
4 agosto 2025
Aggiornata il 5 agosto 2025
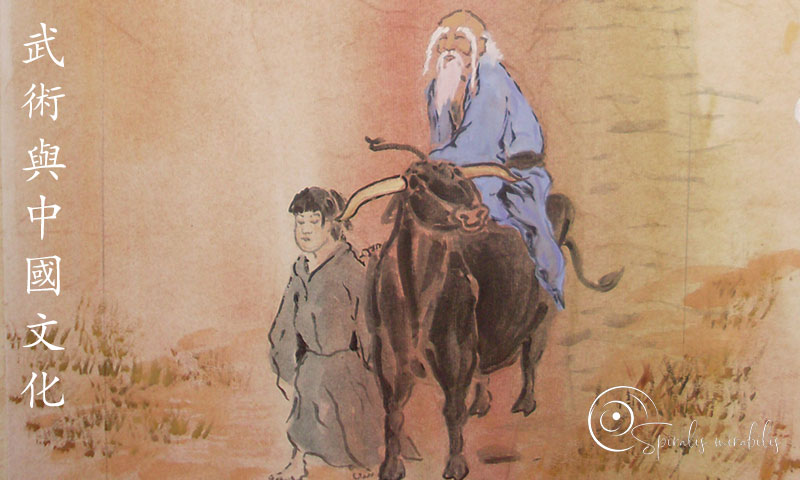
Nel 1972 Mina e Alberto Lupo interpretano uno dei duetti più famosi della televisione italiana "recitando e cantando" la canzone "Parole parole". Una canzone che racconta di una relazione che oramai è fatta di parole vuote e lodi melense senza alcun gesto concreto di affetto.
Volendo fare un'analogia le parole pronunciate da Alberto Lupo sono parole vuote, parole pronunciate "tanto per dire", possono essere presente come esempio di ciò che la visione daoista del mondo esprime riguardo alle parole.
Le parole nella visione daoista hanno un valore limitato e sono considerate "insufficienti" per esprimere la realtà. Le parole sono viste come limitate e parziali, capaci solo di indicare approssimativamente la realtà ma mai di "catturarla", descriverla in modo completo.
Le parole sono considerate strumenti imperfetti e spesso ingannevoli. Nonostante questo sono indispensabili.
Bruce Lee (appassionato studioso di filosofia) in uno dei suoi scritti raccolti nel libro "Il Tao del Dragone" riflette proprio su questo aspetto delle parole e sottolinea come lo stesso autore (o autori) del 道德經 dàodéjīng ha avuto bisogno di circa cinquemila caratteri per esprimersi.
Questa premessa è fondamentale per soffermarsi in questo articolo sul significato delle parole 老師 lǎoshī, 師父 shīfu, 師傅 shīfù.
Dare a queste parole una definizione è possibile, ma allo stesso tempo nel momento in cui si cerca di definire una parola la si "cristallizza" nel tempo. Sappiamo anche che una lingua è destinata a "morire" se si cristallizza e non evolve.
Il significato delle parole evolve costantemente, allo stesso tempo le parole sono imperfette nel descrivere la complessità della realtà e della percezione umana, anch'esse in costante evoluzione.
È importante ricordare in questo articolo che si analizzano parole appartenenti alla lingua cinese. Una lingua che possiede ed esprime concetti non sempre presenti in lingua italiana. Una qualsiasi lingua, infatti, è espressione di una specifica cultura e di una specifica visione del mondo.
Allo stesso tempo, come afferma l'ipotesi Sapir-Whorf (relativismo linguistico), la struttura di una lingua influenza in modo significativo il modo in cui le persone che la parlano percepiscono e pensano la realtà.
In altre parole la lingua che parla una persona influenza lo sviluppo cognitivo e la percezione della realtà.
Per questi motivi la traduzione di queste parole in italiano è, inevitabilmente, un’approssimazione che cerca di essere un "imperfetto equivalente". In secondo luogo, utilizzare in lingua italiana parole di un'altra lingua, in questo caso la lingua cinese, va sempre fatto con consapevolezza e cognizione. Altrimenti si rischia di svilire le parole e renderle parole vuote o, peggio, di usarle in malo modo o a sproposito.
老師 lǎoshī, 師父 shīfu, 師傅 shīfù.
Le prime due parole che ho elencato sono utilizzate nella gran parte delle scuole di arti marziali cinesi. Speso però le si usa senza coglierne il loro pieno significato e, alle volte, sono usate in modo non corretto (se non a sproposito).
La parola 老師 lǎoshī nella sua declinazione più generale può essere tradotta in italiano con la parola "insegnante".
Il carattere 老 lǎo può essere tradotto in italiano come "vecchio (riferito a una persona)", "venerabile (persona)" o "esperto". Mentre il carattere 師 shī può essere tradotto come "insegnante", "maestro" o "esperto".
La parola Laoshi può essere tradotta anche con la parola maestro, ma sempre come declinazione della parola insegnante e non con l'accezione (alle volte ammantata da sacralità) che le è attribuita in Italia nel mondo delle arti marziali, di una persona più vicina alla figura di un "guru" che a quella di un'insegnante.
Identifica una persona che insegna una propria particolare competenza o una particolare materia. Con questa parola in Cina si può indicare un professore delle scuole medie, delle scuole superiori, dell’università, un maestro o una maestra delle scuole elementari, un libero professionista che a partita IVA eroga corsi di formazione e così via...
In semplici e poche parole una qualunque persona che insegna. Quindi, in estrema sintesi, una persona che insegna "una qualche competenza" a un’altra persona può essere chiamata Laoshi.
Nel "ruolo" di studente, di studentessa, si possono avere più Laoshi (così come avviene, ad esempio, alle scuole superiori in cui si ha il professore di matematica, quello di italiano e così via).
La parola Laoshi, quindi, indica una "qualifica". Il ruolo, la mansione, che una persona "ricopre" o "svolge".
La parola 師父 shīfu e la parola 師傅 shīfù sono due parole che da un punto di vista fonetico, in lingua cinese, sono pronunciate quasi nello stesso modo, ma che esprimono ruoli e concetti differenti.
Il carattere 父 fù si può tradurre in italiano con il concetto di "padre", mentre il carattere 傅 fù esprime il concetto di "tutore - mentore".
La prima parola è generalmente utilizzata per rivolgersi a un insegnante, a un mentore, a un monaco, a un maestro di arti marziali e così via. Tendenzialmente questo termine è utilizzato in relazione alla presenza di una persona che ricopre il ruolo di apprendista, identificata dalla parola 徒弟 túdì. Parola che non identifica il ruolo di uno studente o di una studentessa, ma specificatamente il ruolo dell’apprendista, di una persona che instaura un legame di interdipendenza con la figura di chi insegna e da cui riceve in "eredità" le conoscenze dal mentore - maestro.
Appare per la prima volta nella storia cinese durante la dinastia 唐 táng.
Chi ricopre il ruolo di shifu, di maestro, ricopre il ruolo di fonte dell’insegnamento, aiuta a trovare risposta non soltanto a dubbi "marziali" ma a quelli della vita in generale. È un mentore, un "padre amorevole". In Cina, infatti, si dice che un maestro è per metà padre.
Caratteristica sottolineata proprio dal carattere Fu presente nella parola.
Per spiegare meglio il concetto, in lingua italiana, possiamo ricorrere alla parola "padrino". Questa parola, infatti, riesce a chiarire al meglio come il "maestro - mentore" ricopre il ruolo di "padre". Di una persona su cui si può fare affidamento.
Allo stesso modo la moglie del maestro diviene 師母 shīmǔ, traducibile in italiano con la parola "madrina".
Nel mondo delle arti marziali cinesi, per divenire shifu e tudi, è necessario passare per una specifica cerimonia: il cosidetto 拜師 bàishī (traducibile in italiano come "rendere omaggio al maestro").
Una cerimonia che ha un valore culturale che preserva e trasmette l’identità collettiva e un valore psicologico che sostiene l’individuo nel suo rapporto con la comunità e con il proprio percorso di crescita interiore.
Questa usanza risale al periodo delle Primavere e degli Autunni. Nella gran parte degli ambiti artigianali, ad esempio, ha lungo è stata presente una cerimonia di Baishi che sanciva il divenire apprendista di un mastro artigiano.
Oggi, nelle scuole di arti marziali, non esiste una codifica standard della cerimonia del Baishi. Non esiste, quindi, un "protocollo standard" a cui fare riferimento. Può, di conseguenza, presentarsi con modalità molto differenti fra loro.
Essere un Tudi nel mondo delle arti marziali non significa semplicemente possedere il titolo di un determinato lignaggio e, quindi, divenire un "erede" di una particolare tradizione marziale, ma prima di tutto significa "essere" parte della famiglia del maestro con cui si celebra il Baishi.
Il Baishi prevede l’adesione a un codice morale e la partecipazione attiva alla vita della famiglia in cui il/la Tudi è accolto/a.
Il Tudi, ovvero il discepolo, in passato viveva letteralmente nella casa del maestro. Oggi, anche se il discepolo non vive con il maestro, può capitare che condivida il pranzo e la cena, che beve il tè, che giochi a carte o che condivida qualsiasi altra attività quotidiana assieme al maestro. Fa tutto ciò che normalmente si condivide in famiglia.
All'interno della scuola dove il Baishi è celebrato, si creano di conseguenza due figure, quella del Tudi e quella dello studente. Figure che hanno un rapporto differente con l'insegnante.
La persona che diviene un Tudi si rivolgerà all'insegnante con la parola Shifu e con lui avrà una relazione differente da quella della persona che assume il ruolo di studente/essa, che si rivolgerà all'insegnante con il titolo di Laoshi.
Chiamare chi insegna con il titolo di Laoshi, anziché Shifu, non significa non portare il dovuto rispetto all'insegnante e che non ci sia una relazione forte fra chi insegna e chi apprende. Anzi.
In Cina si usa, a tal proposito, la seguente frase idiomatica per esprime quanto salda e forte è la relazione fra insegnante e discente: 一日為師終生為父 yī rì wéi shī zhōngshēng wèi fù "Un giorno insegnante, padre per sempre".
Per questi motivi non ha molto senso farsi chiamare Shifu da chi non è un proprio "apprendista - discepolo". La parola Shifu non è un "titolo", non identifica una mansione. Nessuno di noi si farebbe chiamare da chiunque con la parola "papà" solo perché è padre.
Abitudine, purtroppo, che alcuni insegnanti di arti marziali hanno iniziato ad adottare nel presentarsi al pubblico o nel farsi chiamare da tutti gli allievi e le allieve.
La seconda parola (師傅) è più comune. È utilizzata come forma di rispetto nei confronti di una persona che esercita una particolare professione, come un operaio, un tassista, un idraulico, un cuoco, per strada se si vuol chiedere un'informazione e così via.
Ad esempio, salendo su un taxi, ci si può rivolgere al conducente con il titolo di shifu come forma di educazione. In questo caso la si può tradurre con la parola italiana "maestro", ma come la si utilizza in molti dialetti come sinonimo di "capo".
Ci sono delle eccezioni. È sconsigliabile rivolgersi a un medico o a un poliziotto con questo titolo.
Questa parola appare per la prima volta durante il periodo degli Stati Combattenti e identificava la persona che insegnava all’imperatore.
La conoscenza del significato delle parole è fondamentale. Tanto in lingua italiana quanto in lingua cinese. Anzi. Essendo la cultura cinese "molto lontana" dalla nostra diventa fondamentale comprenderla e soprattutto studiarla. In particolar modo chi vuole assumere il ruolo di insegnante di un'arte marziale tradizionale figlia di questa cultura.
Usa le parole con parsimonia, vista la loro imperfezione nel descrivere la realtà, per non renderle del tutto parole, parole, parole, parole parole soltanto parole.... parole vuote.
Metti in pratica la vera conoscenza
實踐真知
shíjiàn zhēnzhī
Francesco Russo
NOTE SULLA TRASCRIZIONE FONETICA
Le parole in lingua cinese quando appaiono per la prima volta sono riportate in cinese tradizionale con la traslitterazione fonetica. A partire dalla seconda volta, la parola è riportata con il solo pinyin senza indicazioni degli accenti per favorire una maggiore fluidità della lettura dei testi.
BREVE PROFILO DELL'AUTORE
Francesco Russo, consulente di marketing, è specializzato in consulenze in materia di "economia della distrazione".
Nato e cresciuto a Venezia oggi vive in Riviera del Brenta. Ha praticato per molti anni kick boxing raggiungendo il grado di "cintura blu". Dopo delle brevi esperienze nel mondo del karate e del gong fu, ha iniziato a praticare Taiji Quan (太極拳tàijí quán).
Dopo alcuni anni di studio dello stile Yang (楊式yáng shì) ha scelto di studiare lo stile Chen (陳式chén shì).
Oggi studia, pratica e insegna il Taiji Quan stile Chen (陳式太極拳Chén shì tàijí quán), il Qi Gong (氣功Qì gōng) e il DaoYin (導引dǎoyǐn) nella propria scuola di arti marziali tradizionali cinesi Drago Azzurro.
Per comprendere meglio l'arte marziale del Taiji Quan (太極拳tàijí quán) si è dedicato allo studio della lingua cinese (mandarino tradizionale) e dell'arte della calligrafia.
Nel 2021 decide di dare vita alla rivista Spiralis Mirabilis, una rivista dedicata al Taiji Quan (太極拳tàijí quán), al Qi Gong (氣功Qì gōng) e alle arti marziali cinesi in generale, che fosse totalmente indipendente da qualsiasi scuola di arti marziali, con lo scopo di dare vita ad uno strumento di divulgazione della cultura delle arti marziali cinesi.
Metti in pratica la vera conoscenza
實踐真知
shíjiàn zhēnzhī
Francesco Russo
NOTE SULLA TRASCRIZIONE FONETICA
Le parole in lingua cinese quando appaiono per la prima volta sono riportate in cinese tradizionale con la traslitterazione fonetica. A partire dalla seconda volta, la parola è riportata con il solo pinyin senza indicazioni degli accenti per favorire una maggiore fluidità della lettura dei testi.
BREVE PROFILO DELL'AUTORE
Francesco Russo, consulente di marketing, è specializzato in consulenze in materia di "economia della distrazione".
Nato e cresciuto a Venezia oggi vive in Riviera del Brenta. Ha praticato per molti anni kick boxing raggiungendo il grado di "cintura blu". Dopo delle brevi esperienze nel mondo del karate e del gong fu, ha iniziato a praticare Taiji Quan (太極拳tàijí quán).
Dopo alcuni anni di studio dello stile Yang (楊式yáng shì) ha scelto di studiare lo stile Chen (陳式chén shì).
Oggi studia, pratica e insegna il Taiji Quan stile Chen (陳式太極拳Chén shì tàijí quán), il Qi Gong (氣功Qì gōng) e il DaoYin (導引dǎoyǐn) nella propria scuola di arti marziali tradizionali cinesi Drago Azzurro.
Per comprendere meglio l'arte marziale del Taiji Quan (太極拳tàijí quán) si è dedicato allo studio della lingua cinese (mandarino tradizionale) e dell'arte della calligrafia.
Nel 2021 decide di dare vita alla rivista Spiralis Mirabilis, una rivista dedicata al Taiji Quan (太極拳tàijí quán), al Qi Gong (氣功Qì gōng) e alle arti marziali cinesi in generale, che fosse totalmente indipendente da qualsiasi scuola di arti marziali, con lo scopo di dare vita ad uno strumento di divulgazione della cultura delle arti marziali cinesi.
Acquista il libro dedicato al senso sulla pratica del Taiji Quan Una tamerice in attesa della sua primavera.
Scarica il nuovo numero di Spiralis Mirabilis, la rivista 100% gratuita dedicata al Taiji Quan ed al Qi Gong clicca qui.
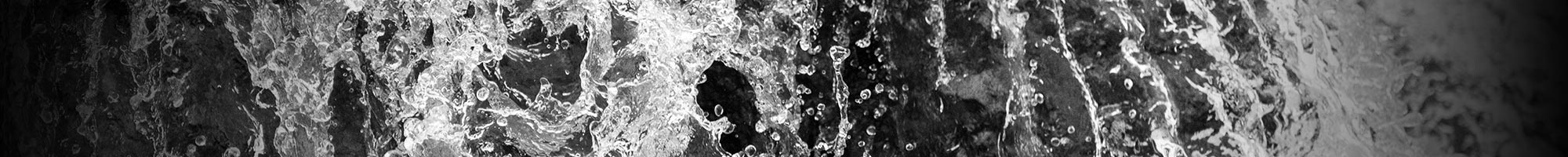
EVENTI
Viaggi
Seminari
Incontri sulla Via
Ⓒ2021 - | Progetto realizzato da BrioWeb C.F. e P.IVA 03853870271 | Informativa sulla privacy e sui cookie